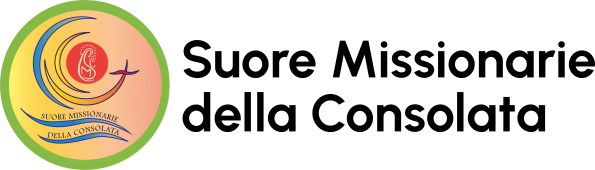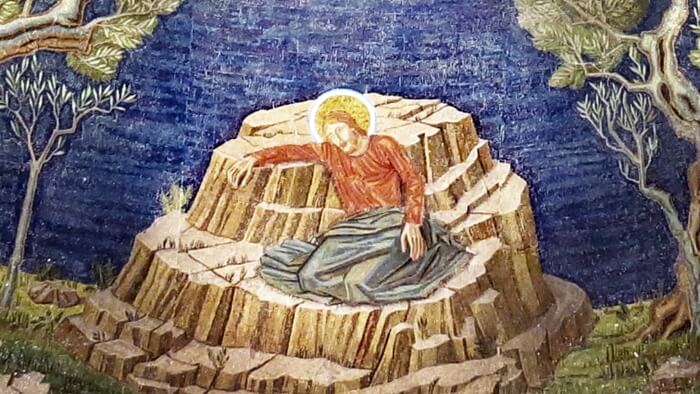La quaresima non avrebbe senso senza la Pasqua, a meno di ridurla a una semplice masochistica penitenza, e la Pasqua non avrebbe forse spessore e profondità senza la quaresima. Ecco perché, solo per questa volta, mi sento di invitare i nostri quindici lettori a pensare insieme questa riflessione e quella del mese prossimo, entrambe in ascolto di un profeta particolare, che ci donerà oggi motivi di afflizione e di triste consapevolezza, ma si aprirà poi a una serenità particolare. In fondo, la fiduciosa speranza alla quale oggi chiamiamo è virtù pienamente cristiana.
Un profeta strano
Noi oggi consideriamo Geremia uno dei tre profeti più importanti, ma ai suoi contemporanei doveva sembrare come minimo strano, se non un menagramo immotivato e insopportabile.
Vive a cavallo tra vii e vi secolo a.C. a Gerusalemme. Poco più di un secolo prima la città era stata assediata dall’invincibile e terribile esercito assiro e, in quel contesto, un altro profeta, Isaia, aveva invitato ad avere fiducia in Dio, che non avrebbe lasciato distruggere il suo tempio. E, in effetti, dopo qualche mese l’esercito nemico se ne era andato senza espugnarla e non era più tornato. Al tempo di Geremia quell’impero era andato in crisi ed era stato sostituito da quello babilonese, che tentava minaccioso di espandersi anche sulle coste del Mediterraneo. Stavolta, però, sembrava che i giudei potessero contare su un’alleanza difensiva con il forte Egitto. Senza contare che quella promessa divina di tutela del tempio non poteva essere decaduta.
Geremia, però, non la pensa così. Invita i suoi concittadini, se vogliono seguire il desiderio divino, ad aprire le porte della città e lasciare distruggere il tempio. Sembrava impossibile: il tempio di Gerusalemme, infatti, non era semplicemente quello che per noi potrebbe essere una chiesa, fosse pure San Pietro in Vaticano: il tempio era «il luogo che Dio si è scelto per porre la sua dimora in mezzo agli uomini», era la presenza divina nel mondo, qualcosa di più simile a ciò che per i cristiani è l’eucaristia. E Geremia invitava a lasciarlo distruggere! Sembrava una bestemmia!
Una tale posizione, oltre accuse di disfattismo, poteva sembrare smentire anche l’antica profezia (riuscita!) di Isaia. Dio poteva aver cambiato idea?
Si capisce che qualche responsabile del tempio (nella fattispecie, il sacerdote Pascur figlio di Immer) si senta in dovere di rimproverarlo minacciosamente, per farlo tacere. Geremia gli risponde con durezza, come si conviene a un profeta di Dio. Solo che poi…
Un profeta in crisi
Poi però, improvvisamente, la grinta del profeta sembra svanire in un lamento. «Mi hai sedotto e io sono stato conquistato. Mi hai violentato e sei stato più forte» (Ger 20,7). Non è un linguaggio di amore, Geremia sembra parlare di sopraffazione. Non un amante tenero e affettuoso, ma un seduttore violento ed egoista. Come è possibile? Che cosa è successo a Geremia?
«Quando parlo, devo gridare “Violenza e oppressione”, e per questo mi prendono sempre in giro. Mi scherniscono perché continuo a parlare di terrore. Mi chiamano “Terrore all’intorno!”. E sperano che io cada, si dicono che basta che qualcuno inizi a denunciarmi, che gli daranno ragione e proveranno a liberarsi di me» (Ger 20,8.10). Le parole del testo biblico non sono precisamente queste ma il loro senso più o meno lo è.
Più avanti, dopo qualche versetto più positivo, il profeta calca ancora di più la mano: dichiara maledetto il giorno in cui è nato, maledice l’uomo che ha portato al padre la bella notizia della nascita di un maschio, ossia libero di parlare in pubblico, sogna il grembo materno come sua tomba (Ger 20,14-18). Rifiuta il bene massimo per tutti gli autori biblici, vale a dire quello della vita, dono divino per eccellenza.
Sembrerebbe quasi che il profeta sia irritato e spaventato dal suo stesso messaggio, si ritrovi incasellato in una parola divina che non condivide. Afferma anche, infatti, di aver provato a tacere, a non parlare più in nome di Dio (v. 9).
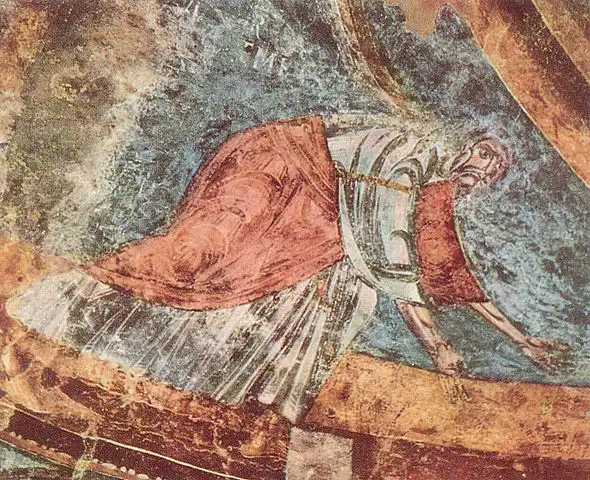
Una voce originale
Un messaggio di questo tipo è straordinario. Troviamo a volte in alcuni salmi o in Giobbe l’invocazione della morte, ma sempre come alternativa a una vita che si è fatta insostenibile per le persecuzioni, per le sofferenze, le malattie… Tutti quei salmisti si sentivano in fondo allontanati da Dio, e in quella situazione invocavano la morte. Geremia, invece, questa separazione dal suo Signore la desidera, è da lui che vuole essere liberato.
Che cosa è accaduto?
I profeti avevano sempre costituito una voce particolare, nel mondo ebraico. Erano coloro che intuivano il cuore di Dio, ciò che il Signore avrebbe pensato di situazioni, contesti e scelte umane. La loro era la voce di chi non passava da un’interpretazione rigorosa della Parola di Dio già data, ma che sapevano intuire il nuovo, ciò che l’Altissimo non aveva ancora detto ma certamente pensava. La verifica del loro messaggio, allora, non poteva passare dal controllo di ciò che era già stato detto in passato: bisognava affidarsi all’interpretazione dei profeti, fidarsi della loro parola, che non fosse una profezia falsa. La mancata attuazione delle loro eventuali previsioni avrebbe in effetti significato che non erano affidabili. Questa verifica però sarebbe arrivata solo quando la parola del profeta non sarebbe più stata utile. Prima di allora, la credibilità del messaggio profetico passava dalla sua persona: quanto più credibile e affidabile era lui, tanto più sarebbe stata da ascoltare la sua parola.
Questa impostazione, probabilmente, aveva fatto crescere anche la consapevolezza dell’individualità del profeta. Un sacerdote, in fondo, interpretava la parola di Dio già detta in un modo che voleva essere oggettivo. Che fosse lui o un altro sacerdote a interpretarla, non avrebbe dovuto essere diverso.
 Con i profeti era differente, sostenevano che fosse stato il Signore stesso in persona a parlare loro. Diventavano qualcuno, diverso dagli altri. Il loro rapporto di fede diventa inevitabilmente personale.
 Al punto che Geremia può porsi davanti al suo Dio non come un semplice esecutore dei suoi comandi, quasi uno schiavo, bensì come una persona autonoma che non apprezza allo stesso modo tutti i messaggi che deve veicolare. E, in particolare, si direbbe proprio che quella “violenza e oppressione” che il profeta deve proclamare è precisamente ciò che non vorrebbe ascoltare neppure lui.
Fuoco ardente nelle ossa
Ritorniamo al versetto 9, chiave preziosa per entrare nell’animo di Geremia, che sostiene di essersi proposto di smettere di profetizzare: «Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!». È la separazione del profeta dal suo Signore. Ma non è una separazione di lunga durata: «Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo».
Rimane la separazione delle volontà: Geremia non vuole ciò che vuole Dio. Ma qui non c’è più seduzione e violenza. C’è il tentativo di chiudere una relazione, e la scoperta che ciò non è possibile, che è il profeta stesso a non riuscire a fare a meno di parlare, di continuare a relazionarsi con il suo Signore. Ci troviamo di nuovo di fronte a una relazione a due, che torna però ad essere di amore, sia pure di un amore tormentato, faticoso, difficile.
Geremia ci sfida a confrontarci con una fede, un affidamento al Signore, non facili né immediati. È la fede degli animi più tormentati, più inquieti, che a volte sognano di essere liberi da tanta fatica. Ma che poi sentono che senza quella relazione vivono peggio, che ne hanno bisogno.
È la fede di molti, nel nostro tempo. È una fede chiamata spesso a percorrere sentieri non ancora tracciati. Ma non per questo meno veri o profondi.
Angelo Fracchia