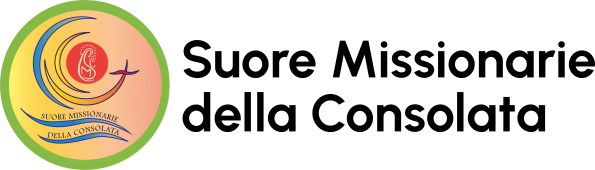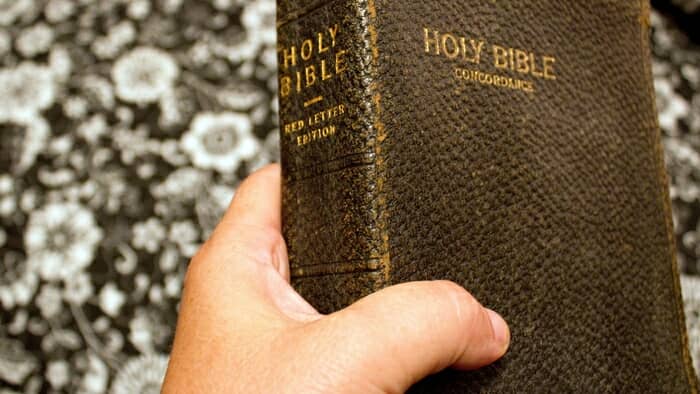Ci sono libri che non capiamo bene che cosa ci facciano nella Bibbia, e che infatti si leggono abbastanza di rado. Eppure, anche quelli hanno inteso comunicare un messaggio…
Uno di questi libri prende il nome dalla protagonista, Giuditta.
Una finzione storica
È una figura che forse conosciamo più dai quadri che dal libro biblico, perché la sua storia, molto violenta e sensuale, si prestava a una resa artistica senza poter essere accusati di immoralità, dal momento che si metteva in scena un racconto della Scrittura. Il libro, in realtà, fa parte delle aggiunte greche alla Bibbia ebraica, benché il tema si presti a esaltare l’orgoglio ebraico.
Si racconta infatti che l’assiro Nabucodonosor, irritato dalla mancata collaborazione di tutte le popolazioni del Vicino Oriente contro Arfacsad, re dei Medi che si era ribellato a lui, decide, dopo aver soggiogato il ribelle, di castigare tutte le altre popolazioni saccheggiandole e sterminandole. Oloferne, generale dell’esercito e secondo in grado nell’impero, arrivando nella regione di Israele, viene informato da Achior, comandante degli ammoniti, che gli ebrei erano difesi da Dio e non sarebbe stato possibile batterli. L’affermazione è particolare, perché gli ammoniti sono sempre stati nemici degli ebrei. Oloferne, però, ribatte: «Chi è dio se non Nabucodonosor?» (Gdt 6,2). Legato Achior, lo deposita alle porte di Betulia, città fortificata degli ebrei, che poi provvede ad assediare.
I particolari storici sono intenzionalmente inventati, e qualunque lettore minimamente informato sulla storia del Vicino Oriente lo avrebbe facilmente capito: Nabucodonosor era stato un imperatore babilonese e non assiro, mentre il contesto imperiale ritratto, e il nome di Oloferne, sembrano rimandare ai persiani. I nomi ebraici citati sono vissuti in altri tempi o sono sconosciuti. La stessa protagonista, il cui nome potrebbe semplicemente significare “giudea”, riceve la più lunga genealogia riservata a una donna nel Primo Testamento (Gdt 8,1), ma con nomi che ci sono quasi tutti sconosciuti. In più, non è mai esistita nessuna città ebraica che si chiamasse Betulia.
L’autore, però, non è uno sprovveduto: piuttosto, fa come chi oggi inventa una storia ambientandola in un medioevo mezzo inventato, per situarla in un passato impreciso ma evocativo e intanto raccontare una vicenda che possa parlare delle dinamiche umane che si danno sempre.
Sempre, pare dirci, il potere assoluto si fa dio e trascura anche i consigli più avveduti, procurandosi la rovina. Nello stesso tempo, finché qualcuno non decide di contrapporsi a quel potere, quello sembrerà invincibile.

Lo scontro
Quando Oloferne arriva davanti a Betulia, sono i nemici tradizionali di Israele, ossia idumei, moabiti e “abitanti della costa”, a suggerire il da farsi: non attaccare la città, che è ben difesa dai monti (sembra la posizione di Gerusalemme…), ma assediarla e prendere possesso della sorgente che porta l’acqua all’interno delle mura, così da costringere gli assediati a morire di sete.
E così accade: dopo trentaquattro giorni gli abitanti del paese chiedono al re Ozia di aprire le porte: meglio finire schiavi che morire. Il re chiede ancora cinque giorni di pazienza, dopo di che, se non accadrà nulla, si consegneranno al nemico.
È a questo punto che entra in scena Giuditta, rimproverando i capi della città di aver voluto mettere alla prova Dio, con il dare un termine entro il quale avrebbero atteso la liberazione o si sarebbero arresi, e garantendo che entro quel termine lei avrebbe procurato l’intervento divino.
Di Giuditta ci era stato detto che era vedova da poco più di tre anni, ricca e molto bella, e che non si era voluta risposare pur non avendo figli (contravvenendo quindi alla legge del levirato…), ma che aveva vissuto nel lutto e nella penitenza, esclusi i giorni di festa religiosa. Stavolta, però, si veste e agghinda in modo da mostrare tutta la propria bellezza prima di presentarsi all’accampamento di Oloferne.
A lui spiega che in effetti lo sterminato esercito assiro non potrebbe aver ragione di Betulia, perché efficacemente difesi da Dio, se solo i suoi abitanti continuassero a rispettare le norme alimentari che però, con la carenza d’acqua, stanno già violando. In più, avrebbero chiesto a Gerusalemme la possibilità di nutrirsi dei beni sacri. Nel momento in cui inizieranno a farlo, dichiara Giuditta, non potranno più resistere di fronte all’esercito di Oloferne.
Il comandante le crede e in più resta sedotto dalla sua bellezza, in modi molto maschilisti e grevi: «Sarebbe disonorevole per la nostra reputazione se lasciassimo andare una donna simile senza fare sesso con lei» (Gdt 12,12). Per questo la invita a una cena con l’intenzione di ubriacarla, ma finisce con il bere più di lei e con l’essere vinto dal sonno. È a questo punto che Giuditta, che aveva ricevuto l’autorizzazione di muoversi nell’accampamento nemico, penetra nella stanza del generale e lo decapita con la sua spada. Quindi ritorna a Betulia con la testa di Oloferne che, mostrata dalle mura della città, getta il panico nell’esercito avversario, che viene quindi assaltato e disperso.
Il senso
Perché raccontare una storia del genere, lunga e piena di violenza, inganni e ambiguità?
Giuditta viene presentata come una donna modesta, rispettosa delle consuetudini di vedovanza e delle regole religiose. Nello stesso tempo, però, pare quasi distaccata dalla sorte dei suoi concittadini (non si era accorta della scarsità d’acqua?) e non si premura di fornire una discendenza al marito morto, secondo la legge del levirato. Quando poi si presenta davanti a Oloferne, dichiara di rispettare le norme religiose, ma si abbiglia e presenta come una donna disponibile a essere sedotta.
Chi scrive questo libro, insomma, pensa certamente alla sorte di un popolo che si sente oppresso e assediato, intende difendere la sua autonomia e il suo legame con il Dio dei padri, ma pare anche insistere sul fatto che la fedeltà più autentica passa dall’intimo del cuore, dalle intenzioni più che dalle forme esteriori, che possono anche essere ambigue o non perfette. Nel racconto del libro si potrebbe addirittura dire che l’intervento salvifico di Dio non c’è (l’esercito assiro non viene sterminato da una epidemia o respinto da interventi prodigiosi o da visioni spettacolari), anche se, più in profondità, Dio interviene ma con la collaborazione della disponibilità, dell’intelligenza e del coraggio delle persone. È la schiettezza e trasparenza di Achior, appartenente a un popolo nemico degli ebrei ma che riconosce l’assistenza divina su di loro e alla fine si unirà al popolo (Gdt 14,10, in violazione delle norme volute da Mosè: Dt 23,4-5). Ed è l’intelligenza e il coraggio di Giuditta, una donna vedova, quindi fragile ed esposta, benché ricca e bella. «Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor!» (Gdt 14,18).
Un Dio che davvero interviene nella storia, quindi, a salvare i suoi fedeli. Ma non lo fa con interventi magici, bensì con la collaborazione e l’intervento attivo di chi lo ascolta e si mantiene in relazione con lui.
Angelo Fracchia – Biblista