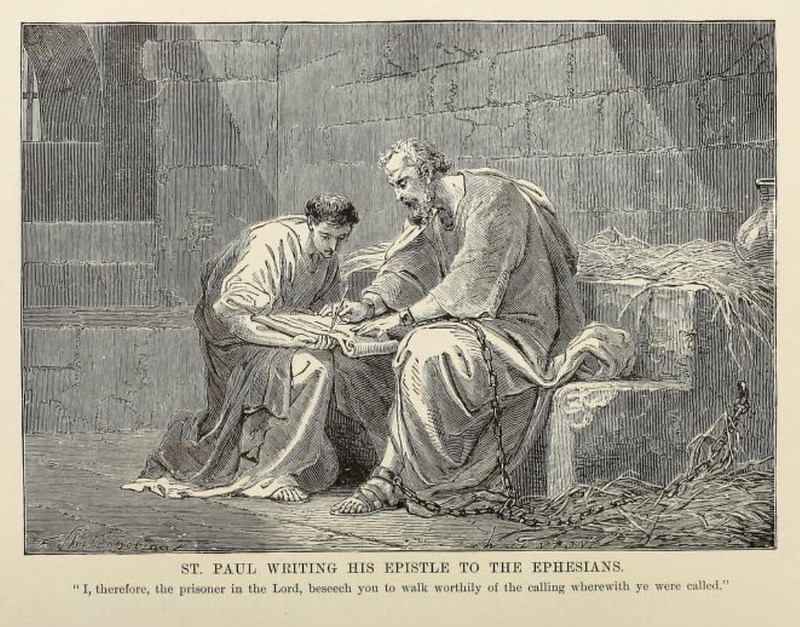Nel Nuovo Testamento troviamo alcuni inni a volte per noi un po’ più difficili da seguire, perché non sono delle storie o delle definizioni teologiche, ma che rappresentano le più antiche preghiere cristiane (solo il “Padre nostro” è più vecchio ancora…).
Anche se ci sarà forse da faticare un pochino, può diventare davvero interessante andare a leggere e capire delle reliquie così antiche ed importanti. Una di queste si trova all’inizio della lettera di san Paolo agli Efesini.
La lettera
In realtà non dovremmo insistere troppo sul titolo dello scritto. Tra le lettere attribuite a Paolo, infatti, questa suona molto strana come lingua usata (molto più ampollosa e solenne del suo stile consueto) e come temi, che vanno molto nella direzione della “Chiesa” intesa come complesso universale o addirittura cosmico e non come comunità locale, e verso considerazioni mistiche che sono interessanti ma non erano una questione particolarmente cara a Paolo.
Tra l’altro, non è neppure così sicuro che davvero sia uno scritto destinato agli abitanti di Efeso, città il cui nome compare solo all’inizio, ma che nei manoscritti più antichi manca o è stato aggiunto dopo. D’altronde, mancano anche i saluti personali, così tipici di Paolo, il quale pure aveva lavorato a Efeso per anni, per cui non dovevano mancargli di certo legami e persone care.
Con ciò, questa si riduce, alla fine, a una questione da specialisti. Può darsi che non fosse una lettera per gli efesini e che non l’abbia scritta Paolo, ma comunque è un testo cristiano antico che riflette su temi solenni e mistici (la Chiesa) ma anche quotidiani e concreti (i legami familiari). Chiunque l’abbia scritta e per qualunque destinatario e motivo, è una riflessione che può essere utile anche per noi oggi, e che la seconda generazione cristiana ha ritenuto importante e degna di essere conservata e tramandata.
L’inno
L’inizio della lettera è molto consueto (e, se lo si fosse voluto, facile da imitare). Come si faceva sempre nelle lettere nell’antichità, si parte dal mittente (Paolo, apostolo di Cristo), si indica il destinatario (i santi che sono in Efeso) e si aggiunge un saluto, che nelle lettere paoline si incentra su Dio e a volte si fa molto lungo, mentre qui cita semplicemente il Padre e il Signore (Ef 1,1-2). Semplice, secco, diretto.
Poi inizia l’inno, che sembra potersi dividere in quattro momenti. Non dobbiamo pensare alle strofe ben organizzate, ritmate e rimate della nostra tradizione poetica italiana, ma non corrisponde neanche alle abitudini delle poesie greche antiche. È più un discorso di taglio poetico, che di tanto in tanto sembra fermarsi solo per respirare e poi riprendere. Anche noi usiamo questa divisione in strofe per semplice comodità, così da respirare anche noi nella lettura.
Il progetto del Padre (vv. 3-6)
Si parte benedicendo il Padre e spiegandone il motivo: perché ci ha benedetti (v. 3). Non c’è l’approccio normale, anche per le preghiere, di una lode da suddito a imperatore, lusinghiera e servile, fosse pure per riuscire a ottenerne favori. C’è piuttosto un rapporto quasi alla pari: benediciamo perché ci ha benedetti. È l’approccio cristiano, che sa benissimo che l’umanità è inferiore a Dio, ma sa anche, in Gesù, di essere stati chiamati a vivere con Dio in comunione, in amicizia, alla pari, come si chiarirà già in questa prima strofa.
Si precisa che questa benedizione del Padre è spirituale (sempre v. 3), non mira cioè a farci ottenere chissà quali beni mondani o salute o potenza, ma guarda al nostro spirito, al nostro intimo, alla profondità del nostro essere. Ed è una benedizione che ci arriva non direttamente, ma tramite “Cristo”.
È però una benedizione che non è una novità, non è un piano che al Padre sia venuto in mente all’ultimo, ma l’ha in testa da sempre: fin dalla fondazione del mondo siamo stati chiamati a essere perfetti (v. 4), perché già eravamo destinati a essere figli del Padre, alla pari con lui, come Gesù, con la sola differenza che Gesù lo è per natura, noi per adozione (v. 5). Ecco perché l’inizio dell’inno non era presuntuoso e davvero potevamo trattare Dio faccia a faccia. Non per merito nostro, ma per la «benevolenza del suo volere», perché semplicemente il Padre ha voluto così, generosamente, perché ha un desiderio benevolo. Da sempre ha deciso, senza essere per nulla costretto, che noi umani fossimo come Gesù, in quella stessa comunione intima con lui. Passiamo da Gesù, ma siamo resi come lui.

Pacificazione in Gesù (vv. 7-10)
Seguono quindi tre strofe che si incentrano tutte su Gesù, partendo da un “nel quale” che sempre parla di lui.
Anche la prima strofa, d’altronde, parlava del Padre e di noi eppure doveva sempre passare dal Cristo, che è l’unico nostro tramite con Dio, in quanto è diventato come noi, uomo fino alla morte.
E di morte di Gesù, del suo sangue, parla in effetti la seconda strofa, che non può che passare da lì ma non si incentra su quello.
Non si può non parlare della croce, che dice da una parte, simbolicamente, il sacrificio che ha rimesso i peccati, cogliendo però che si tratta di un sacrificio fatto una volta per sempre, che implica la nostra “redenzione”, ossia il nostro essere riscattati, restituiti a libertà, non più schiavi, passaggio che non deve ripetersi ogni volta, ma è dato una volta per tutte. La croce mostra fino a che punto Dio sia disposto ad amare l’umanità: fino a morire, da parte del Figlio, e fino a lasciare morire colui che ama, da parte del Padre. Abissi irraggiungibili, estremi. Non si può davvero chiedere di più. E nello stesso tempo, siccome tecnicamente quello di Gesù sulla croce non è un sacrificio (non uccide sull’altare nessun animale), quel “sacrificio” suo personale dice che in realtà i sacrifici non serviranno più.
E allora in Gesù scopriamo ciò che Dio da sempre aveva sognato di fare, ossia vivere nella piena comunione con gli esseri umani (v. 9). A quel punto, la vicenda di Gesù diventa la chiave di comprensione della storia intera, il punto d’incontro tra le promesse divine, le attese umane e la storia. Si può davvero dire che «nel Cristo si ricapitoli il tutto» (v. 10), tanto le dimensioni divine (“sopra il cielo”) quanto quelle mondane (“sulla terra”).
Gesù è il centro, ed è un centro che parla di amore tra Dio e gli esseri umani. Per sempre, definitivamente.
Ultime due strofe (vv. 11-14)
Trattiamo insieme la seconda metà dell’inno.
Dapprima chi ha scritto queste parole fa notare che in Gesù siamo stati scelti da sempre (v. 11). Non è un piano di recupero, da parte del Padre, non è la soluzione di ripiego dopo che qualcosa è andato storto.
Dio ha sempre pensato a noi come ai suoi figli per adozione, diversi per natura (siamo creati) ma che, in colui che l’umanità ha saputo conquistarsela, impararla, entrandoci con ciò che abbiamo celebrato a Natale, siamo diventati anche capaci di credere che davvero abbia nei nostri confronti lo stesso progetto di figliolanza. Figli per adozione, non per natura, ma pensati come figli da sempre da parte di colui che non è costretto a nulla, ma semplicemente ama per scelta (v. 11). Lo si era già detto all’inizio, ma davvero è una notizia tanto grande che merita di essere meditata ancora.
A questo punto chi si è affidato a Gesù, chi ha creduto a un piano di amore divino di questo tipo, ha semplicemente riconosciuto che quello è il cuore di Dio, lo mostra, gli “dà gloria” (v. 12). Questa formula non indica la adulazione, ma il riconoscimento di chi si ha davvero davanti. Come chi “glorificasse” un campione sportivo non dicendo che è fortissimo, bravissimo, eccezionale, ma semplicemente raccontando le sue imprese sportive, che dicono chi è (e che magari dicono che è fortissimo, bravissimo, eccezionale, ma spiegando semplicemente la realtà).
I cristiani che si affidano al Padre in Gesù, mostrano l’amore benevolente del Padre, gli rendono gloria.
L’ultima strofa si ricorda di citare anche lo Spirito Santo e guarda al futuro (vv. 13-14). È lo Spirito che pone il sigillo, di fronte alla libera adesione degli esseri umani (la libertà umana non può mai essere saltata, perché non stiamo parlando di leggi fisiche, ma di un incontro tra libertà: quella divina è stata mostrata da Gesù, quella umana si dispiega lungo la storia). Chi scrive queste parole parla addirittura di “caparra”, che indica un possesso non ancora pieno (non siamo ancora nella piena comunione con il Padre, finché viviamo nella storia) ma già garantito, perché nessuno potrà più portarlo via. Quando paghiamo una caparra, sappiamo che il bene che acquistiamo è già inevitabilmente destinato a noi, anche se non lo abbiamo ancora in mano. Allo stesso modo, le due libertà che si incontrano sono certificate dallo Spirito di Dio come un destino che si compirà, anche se ora non è ancora pieno.
Sembrerebbe un sogno: un Dio che vuole la comunione con gli esseri umani, la vuole da sempre e la compirà. Ma non è un sogno: è radicato nella vicenda storica di Gesù, che nella sua vita storica si è mostrato il Figlio che mostra il volto di un Padre buono da sempre e per sempre.
Angelo Fracchia